Wearable, tutti i trend 2018 sul futuro della tecnologia che indosseremo
Novembre è già un mese adatto per tirare alcune considerazioni sull’annata 2017, ormai agli sgoccioli, e così è stato anche per il settore dei Wearables, i dispositivi tecnologici indossabili.
Il 9 novembre, infatti, si sono svolti a Londra i “Wearable Tech Awards 2017” e a farla da padrone è stata FitBit, la cui strategia di crescita, di cui avevo già parlato qui, sembra dare i suoi primi risultati, anche se ancora sul settore fitband e non smartwatch.
Wearable of the Year
Come miglior Wearable e Fitness Tracker, i due premi più ambiti, è stato votato FitBit Alta HR: la perfetta sintesi tra stile e tecnologia,con un design semplice, ma altamente personalizzabile e un ottimo sistema di health tracking.

Come detto, se FitBit la fa da padrone nel settore fitness, nel campo SmartWatch (quello più appetibile dal punto di vista economico e di sviluppo) è Apple ad avere ad oggi ancora i risultati migliori: Apple Watch Series 3 è stato votato come il migliore della categoria per il 2017 grazie al suo design sportivo e alle sue features di altissimo livello (connessione LTE, musica in streaming e health tracking di buon livello).
LEGGI ANCHE: FitBit torna alla conquista del mercato dei Wearable
Tra gli “Highly Recommended” della categoria smartwatch troviamo Louis Vuitton Tambour Horizon, con il suo design classico ed elegante, e proprio per contrastare questo nuovo trend più fashion, Apple è pronta a lanciare sul mercato (14 novembre 2017) Apple Watch Series 3 Hérmes edition, creato in collaborazione con il luxury brand francese.

Smartglasses, c’è vita oltre Google Glass
Wearables non significa solo dispositivi da polso e, per non lasciare ancora per un momento Londra, segnaliamo l’apertura del temporary store di Snapchat Spectacles: una mossa di marketing interessante, che però nasconde un pesante errore di valutazione iniziale: 40 milioni di dollari di prodotti invenduti!
Snapchat ha deciso di puntare sul settore degli Smartglasses, nonostante anche Google avesse deciso di abbandonarlo, soprattutto per problemi legati alla privacy, dovuti anche a un design troppo riconoscibile. Gli Snapchat Spectacles, grazie a un design meno riconoscibile (sembrano normalissimi occhiali da sole) e la sola possibilità di registrare video, stanno avendo un discreto successo e, stando a quanto riferisce il CEO Evan Spiegel, sono riusciti a vendere nel loro primo anno più di iPod.
LEGGI ANCHE: Così Snapchat inizierà a fare series
Sicuramente 40 milioni di dollari di invenduto non sono un grande successo, ma modificare le attitudini dei consumatori con hardware di nuova generazione non è un compito facile. Staremo a vedere!
Un’altra interessante novità legata agli SmartGlasses sono i Raptor della Everysight. Un vero e proprio headset pensato per i ciclisti e gli sportivi in generale (soprattutto sport acquatici) in grado di fornire in tempo reale informazioni utili per l’andamento della gara e dell’allenamento, senza mai staccare gli occhi dalla strada per guardare i computer di bordo posti sul manubrio o il volante.
Wearable per lo Sport
Le ultime due novità Wearables 2017 che andremo a vedere sono sempre legate allo sport business e coinvolgono mani e piedi, terreni ancora pressoché inesplorati dal mondo dei dispositivi indossabili.

Sensoria ha messo in commercio le Smart Running Sneaker, scarpe da corsa dotate di sensori AI nella suola in grado di rilevare l’impatto tra il piede e il suolo, prevenendo così la possibilità di infortuni. Le informazioni e le metriche, riguardo al passo, alle calorie consumate, al tempo e la distanza, vengono comunicate sia audio che video grazie alla connessione con un’app specifica scaricabile da smartphone.
Ultima novità legata al mondo dello sport: Visa introdurrà alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 gli Smart Gloves, guanti invernali per il pagamento contactless. Non solo guanti contactless:Visa ha preparato anche una serie di spille e adesivi dotati di tecnologia NFC e quindi utilizzabili per i pagamenti.
Ancora una volta, il futuro delle tecnologie wearable mobile passa dallo sport, ma siamo sicuri che il futuro vedrà questi nuovi device conquistare molti altri settori: proviamo a fare qualche previsione insieme?



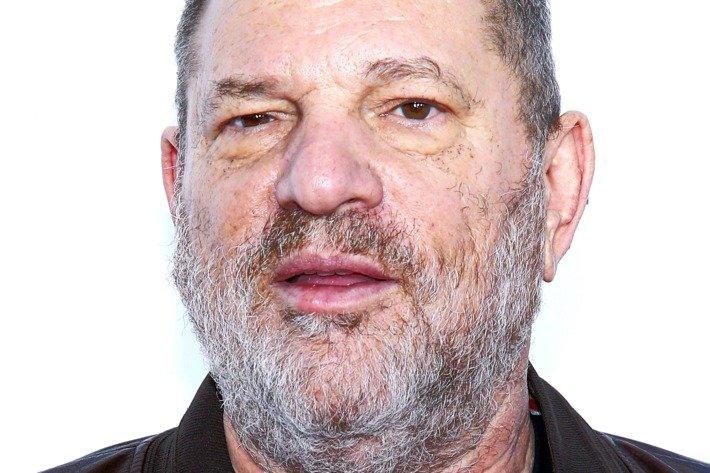

















 Non è bello ciò che è bello. Ma è bello ciò che piace
Non è bello ciò che è bello. Ma è bello ciò che piace Al posto giusto. Nel momento giusto
Al posto giusto. Nel momento giusto Immaginare e creare. sempre
Immaginare e creare. sempre


















