Cosa abbiamo imparato dal caso Pandora (noi e chi lo ha sfruttato al volo)
L’ennesimo articolo sul “caso Pandora”? Sì, ma abbiamo voluto attendere per dire la nostra e per poter analizzare tutte le reazioni alla storia che ha riempito i nostri feed negli ultimi giorni.
Premessa: probabilmente qui non troverai una presa di posizione sulla campagna di Pandora e sul messaggio pubblicato dall’azienda, ma più un’analisi dei commenti, dai social, alle testate, fino all’offline e al bar sotto casa, per capire in che modo alcuni messaggi agiscano sulla nostra pulsione ad una reazione.
Un piccolo ripasso
«Un ferro da stiro, un pigiama, un grembiule, un bracciale Pandora: secondo te cosa la farebbe felice?»: ecco la domanda al centro della polemica posta dal marchio di gioielli Pandora. La scritta a caratteri cubitali su sfondo verde campeggia in diverse fermate della metropolitana di Milano e non tarda a scatenare le reazioni indignate di associazioni e donne sui social network, per gli evidenti stereotipi femminili inseriti.
Voluta o no, la reazione è immediata e tocca un nervo scoperto del dibattito italiano odierno.
E Pandora è dovuta correre ai ripari anche con una serie di post sulla propria pagina Facebook.

La prima associazione che viene facile fare è quella con l’altra recente campagna che aveva scatenato la Rete: la pubblicità di Buondì Motta, che ci ha fatto parlare per settimane e schierarci come se quella presa di posizione fosse vitale per definire la nostra identità. Pro e contro, era diventato una sorta di dibattito in cui gli ortodossi si contrapponevano ai progressisti, dell’idea di famiglia in quel caso, ma anche dell’idea di pubblicità in senso più ampio. E Motta, insieme all’agenzia creativa ideatrice della campagna, aveva ben saputo cavalcare l’onda.
Ma potremmo anche pensare all’altro recentissimo caso della censura delle opere di Schiele nella metropolitana di Londra. Manifesti con i quadri di uno dei più grandi esponenti dell’espressionismo erano stati affissi su iniziativa dell’ente del turismo austriaco in tutta Europa per pubblicizzare la serie di mostre a Vienna in occasione del centenario della scomparsa del maestro, ma i manifesti con il Nudo maschile seduto e la Ragazza con calze arancioni, sono stati rifiutati dalla compagnia dei trasporti londinese che li ha ritenuti troppo osé. Semplice la risposta di Vienna, che in modo davvero intelligente ha inviato le stesse opere, ma stavolta censurate dalla scritta «SORRY, 100 years old but still daring today» (Ci dispiace, hanno cento anni ma sono ancora troppo audaci). Alla nuova campagna di promozione turistica è seguito l’hashtag #ToArtItsFreedom, che riprende lo slogan «Ad ogni età la sua arte, ad ogni arte la sua libertà» dei secessionisti viennesi nel 1897.

In Italia, invece, la polemica si sposta su quello che sembra essere un altro punto dolente per la nostra società: il ruolo della donna, il modo di intendere il femminismo e ancora una volta il modo di fare di questi temi pubblicità.

Giornali, social network e chiacchiere da bar
Abbiamo cercato di non limitarci al web e per questa analisi abbiamo passato in rassegna i titoli dei giornali, i gruppi su Facebook (da quelli di Mamme a quelli di Creativi), le pagine e gli account social di altre aziende sempre pronte a seguire il flusso del real time marketing, ma anche i commenti degli avventori dei bar e delle donne nei supermercati. Ci siamo letteralmente messi in ascolto, perché non riuscivamo a capire quale fosse il registro corretto per leggere il copy della discordia.
Un dato ci è apparso subito chiaro: per riuscire a porre un dubbio sulla chiave di lettura della campagna, voluto o non voluto, il testo dell’affissione ha raggiunto un livello semantico quasi letterario, imponendo appunto una riflessione sulle differenze tra significante e significato, che, visti i risultati in termini di diffusione, neanche i creativi autori del copy probabilmente vorranno mai più davvero confermare o smentire.
LEGGI ANCHE: Jonah Berger a Ninja: «L’influencer marketing è sopravvalutato»
“Ma questa pubblicità, cosa voleva dire davvero”
Per cercare di affrontare al meglio la questione sembra utile classificare tre categorie di reazioni di fronte al messaggio della campagna in generale e dell’affissione più nello specifico (anche se gli spot TV offrono una chiave di lettura forse un po’ più chiara e meno polemica del tema affrontato).
- Il messaggio così com’è;
- una forte disattenzione al ruolo e alla figura della donna di oggi;
- chi non ha capito l’ironia del messaggio è un “analfabeta funzionale”.
Partiamo dal gradino più basso dell’interpretazione, quello più semplice, che paradossalmente però richiede più impegno, perché ci impone di liberarci da preconcetti e approcci personali ed emotivi alla lettura. In questo tipo di decodifica il messaggio della campagna Pandora, diventa un semplice consiglio agli uomini, ancora incapaci di capire cosa piace davvero alle donne e quindi anche di scegliere un regalo davvero adatto per le proprie mogli, compagne, figlie, sorelle. L’azienda, come è ovvio che sia, suggerisce di non sbagliare e di puntare sul proprio prodotto.
Limpido, chiaro, almeno fin qui. Almeno astraendoci da quel famoso contesto, che poi è quello che ci spinge a provare reazioni, a reagire e anche a condividere.
Un bravo pubblicitario, penseremo tutti, non può non considerare il contesto e quindi non può non aver pensato alle reazioni, soprattutto nell’epoca dei social.
E questo, ovviamente, ci porta alla seconda categoria della nostra interpretazione, che poi è probabilmente anche il secondo livello del messaggio della campagna di Pandora. Moltissime donne e tanti polemici della tastiera non aspettavano altro per indignarsi. Finalmente un nuovo caso, pane per le loro dita in cerca di nuove storie su cui digitare in fiumi di post tutte le considerazioni sulla società contemporanea, soprattutto quella italiana ancora troppo machista e poco attenta alle reali esigenze delle donne.
Qui non rientra solo chi si è indignato per il messaggio anti-femminista (le donne sono ancora le casalinghe costrette a stare in casa come tutrici del focolare domestico), ma si può far ricadere anche un particolarissimo target femminile, ossia quello opposto, delle donne che davvero preferiscono detersivo e guanti di plastica a qualsiasi altro regalo, perché la casa e la cura dei propri cari sono il loro unico scopo di vita. Forse qualcuno le ha conosciute solo come le mitologiche “mammine pancine” tanto bistrattate dal Signor Distruggere, ma donne che scelgono di dedicarsi totalmente alla famiglia e alla casa oggi ne esistono ancora davvero e spesso sono molto più giovani dei quelle che crediamo. Ma questo è un capitolo a parte, a cui andrebbe dedicata un’analisi sociologica più che un articolo sull’advertising.

Tra i professionisti del settore Marketing e Comunicazione, il parere che mi è sembrato essere più condiviso è quello della consapevole ironia con cui i creativi hanno confezionato questo messaggio, per un brand che proprio nel periodo natalizio vede schizzare in alto le sue vendite.
In realtà, insomma, tutti a Natale regalano le stesse cose e anche il bracciale Pandora fa parte dei cliché, ma almeno sarebbe un oggetto più gradito ed emozionante da ricevere per una donna.
In questa categoria naturalmente va annoverato anche chi ha colto l’occasione per ironizzare nel senso opposto: per tante donne, forse più concrete e meno vanesie, molto meglio il pigiama e il ferro da stiro come regalo, che un altro gioiello che non si sa bene in quale occasione sfoggiare, perché tra le corse in treno per il lavoro e il torna-a-casa-prendi-i-bambini-rimettiti-al-pc-mentre-il-marito-cucina il tempo da dedicare un po’ a stesse manca sempre. Insomma, non solo i saggi della comunicazione, gli addetti ai lavori che si sentono investiti dell’unico vero diritto di dare il loro parere definitivo sulla questione, perché loro con queste cose ci lavorano, ma anche quelle specie di super-women che ogni giorno devono confrontarsi con le sfide della vita reale e sanno che l’unico modo per farlo è viverle con la leggerezza di un sorriso.
Qui, quella che sembra essere l’unica voce a favore è della direttrice di Donna Moderna, Annalisa Monfreda, all’interno di una categoria giornalistica che si è chiaramente schierata per l’interpretazione della campagna come deviato messaggio maschilista.
La campagna Pandora e l’inevitabile real time marketing
Tralasciando la reazione un po’ esasperata di chi ha chiesto addirittura l’intervento della Consigliera alle Pari Opportunità del Comune di Milano per rimuovere l’affissione dai corridoi della metro, tanti brand non hanno saputo resistere a rispondere con il loro real time sui social e noi non sappiamo resistere a riportarne una breve raccolta.


E quindi, cosa dobbiamo pensare della campagna Pandora?
La conclusione? Come dicevamo all’inizio nessuna presa di posizione sulla campagna di Pandora in senso stretto, ma la presa di coscienza che il nostro punto di osservazione è quello che più conta per generare il giudizio, soprattutto grazie o a causa dei social. Il rischio è quello di limitarsi ai pareri della propria cerchia e di non confrontarsi mai con l’opinione differente, restando ancorati alla fine a false certezze che ci siamo creati più per pigrizia che per vera motivazione.



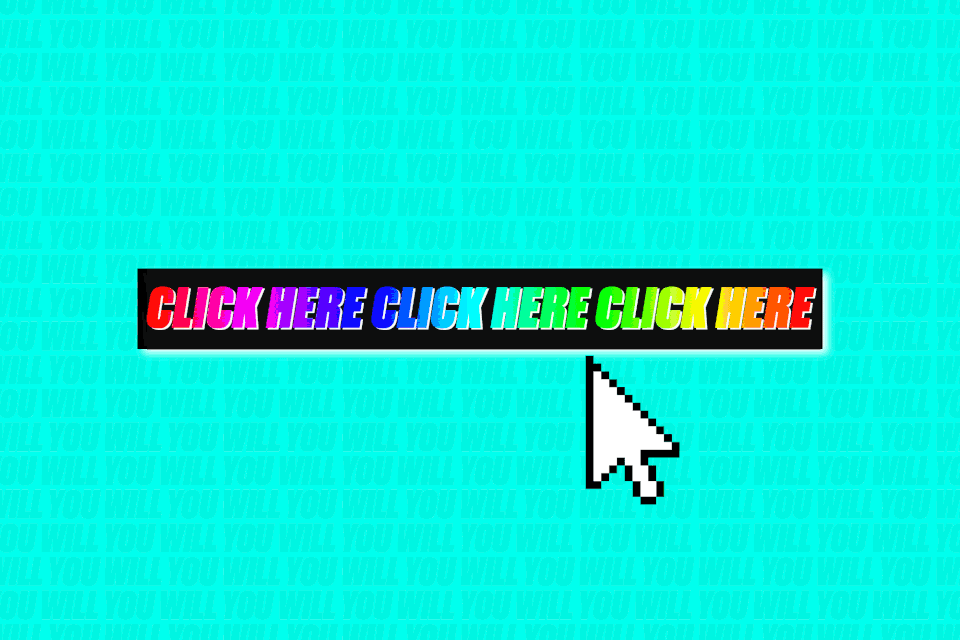

























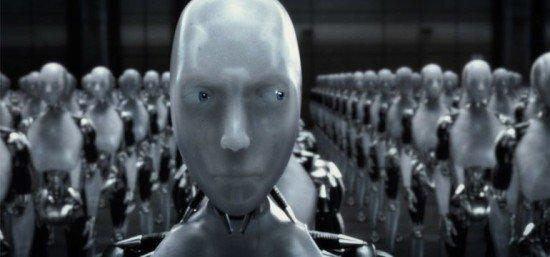


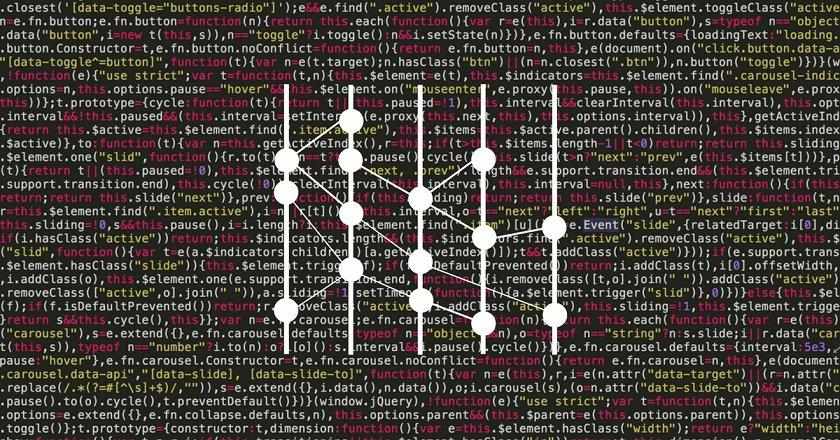
 Social media
Social media
























