I rischi per le aziende (e per i dipendenti) che non hanno una policy per i social
L’utilizzo sempre più frequente delle piattaforme social disponibili sul web e di libero accesso a tutti non ha mancato di impattare, sia in positivo che in negativo, sui rapporti di lavoro
9 Maggio 2019
I social network, nati in origine per un uso strettamente privato come libera “piazza” per esprimere opinioni di qualsiasi genere e con qualsiasi tono, hanno conquistato anche la sfera lavorativa diventando veri e propri strumenti di lavoro.
Basti pensare a Facebook Workplace o a sales navigator di LinkedIn, dove il social diventa piattaforma lavorativa collegandosi direttamente al profilo personale del lavoratore.
La stessa WhatsApp è diventata una chat lavorativa in cui scambiarsi in tempo reale aggiornamenti sulle operazioni, magari nel gruppo aziendale, tra una sbirciatina e l’altra alle notifiche personali.
LEGGI ANCHE: Privacy, pagamenti ed eCommerce: le novità annunciate per Facebook, WhatsApp e Instagram all’F8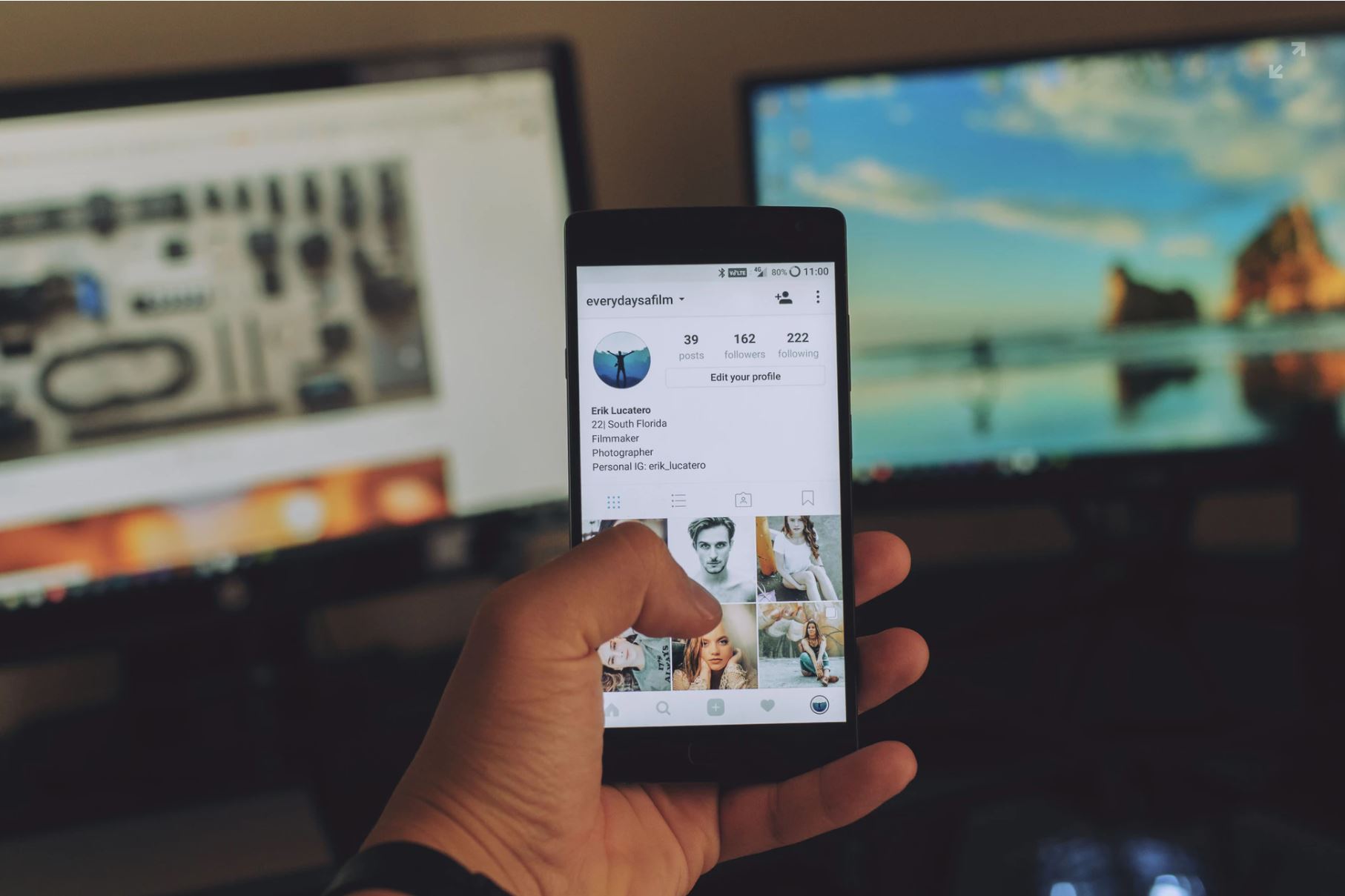 Ma non solo. Le aziende adottano i social network perché vogliono ampliare il proprio business, e capita che provino a spronarli (anche attraverso incentivi) a promuovere il brand aziendale e trasformando gli stessi, indirettamente, in digital ambassador, senza però regolamentare questa prassi ai limiti della correttezza tra le parti.
Fin qui, sembrerebbe che i social mettano d’accordo entrambe le parti, in una conviviale piattaforma sociale libera e felice. La realtà è molto più oscura.
Per il lavoratore, la sottile sovrapposizione che si ottiene dall’utilizzo dei social per motivi di lavoro e la tentazione di utilizzarli per scopi privati, durante l’orario lavorativo e magari con mezzi strumentali dell’azienda, è fortissima; di contro, per il datore di lavoro, sembra essere diventata quasi un diritto/dovere imprescindibile l’attività di spionaggio dei profili social del dipendente cercando di allargare i confini del suo potere di controllo.
Ma non solo. Le aziende adottano i social network perché vogliono ampliare il proprio business, e capita che provino a spronarli (anche attraverso incentivi) a promuovere il brand aziendale e trasformando gli stessi, indirettamente, in digital ambassador, senza però regolamentare questa prassi ai limiti della correttezza tra le parti.
Fin qui, sembrerebbe che i social mettano d’accordo entrambe le parti, in una conviviale piattaforma sociale libera e felice. La realtà è molto più oscura.
Per il lavoratore, la sottile sovrapposizione che si ottiene dall’utilizzo dei social per motivi di lavoro e la tentazione di utilizzarli per scopi privati, durante l’orario lavorativo e magari con mezzi strumentali dell’azienda, è fortissima; di contro, per il datore di lavoro, sembra essere diventata quasi un diritto/dovere imprescindibile l’attività di spionaggio dei profili social del dipendente cercando di allargare i confini del suo potere di controllo.
Le insidie dell’uso dei social network per lavoro
La giurisprudenza si sta esprimendo sempre più frequentemente, prendendo decisioni di merito e legittimità in relazione ai licenziamenti disciplinari irrogati a dipendenti che mantenevano condotte improprie sui social network o a datori di lavoro che violano i diritti di privacy e riservatezza dei lavoratori. Casi eclatanti hanno portato addirittura al licenziamento del lavoratore, in altri situazioni la giurisprudenza è rimasta più prudente ed in Cassazione ha risolto i conflitti comminando un provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore o obbligando il datore di lavoro a risarcire il dipendente a seguito di un abuso dei poteri direttivi.
LEGGI ANCHE: I leader migliori insegnano (e i dipendenti migliori vogliono imparare)
La sentenza della Cassazione n. 10280/2018, per esempio, ha analizzato il caso del licenziamento di una lavoratrice che aveva postato, sulla propria bacheca di Facebook, frasi ingiuriose nei confronti dell’azienda per cui lavorava e nei confronti del datore di lavoro.
Casi eclatanti hanno portato addirittura al licenziamento del lavoratore, in altri situazioni la giurisprudenza è rimasta più prudente ed in Cassazione ha risolto i conflitti comminando un provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore o obbligando il datore di lavoro a risarcire il dipendente a seguito di un abuso dei poteri direttivi.
LEGGI ANCHE: I leader migliori insegnano (e i dipendenti migliori vogliono imparare)
La sentenza della Cassazione n. 10280/2018, per esempio, ha analizzato il caso del licenziamento di una lavoratrice che aveva postato, sulla propria bacheca di Facebook, frasi ingiuriose nei confronti dell’azienda per cui lavorava e nei confronti del datore di lavoro.
Si può essere licenziati se si parla male dell’azienda sui social
In questo caso, la Cassazione ha confermato il licenziamento per giusta causa, comminatole dal datore di lavoro, in quanto le giustificazioni portate dalla lavoratrice ovvero “era uno sfogo personale fine a se stesso”; “non sapevo potesse diffondersi pubblicamente”, non erano considerate sufficienti per annullare il licenziamento. Emerge quindi un concetto importante, i social non sono indenni dal reato di diffamazione e questa sentenza lo dimostra in modo chiaro. LEGGI ANCHE: Investire sul benessere dei propri dipendenti fa bene alle aziende I social sono una cassa di risonanza molto grande, un semplice post può infatti raggiungere un numero elevato di persone che non solo lo leggono, ma interagiscono attraverso ricondivisioni, commenti e like, alimentando il reato di diffamazione e aggiungendo anche l’offesa a mezzo stampa. Va sottolineato però, che se la lavoratrice in questione avesse utilizzato Facebook con una privacy policy restrittiva, impendendo ad estranei (non solo ad amici e parenti) di visitare il proprio profilo, nulla di quanto sopra si sarebbe verificato, poiché le frasi ingiuriose postate erano rese disponibili ad un gruppo ristretto di amici, riservate quindi ai soli soggetti autorizzati dal titolare del dato e non di pubblico dominio.
Va sottolineato però, che se la lavoratrice in questione avesse utilizzato Facebook con una privacy policy restrittiva, impendendo ad estranei (non solo ad amici e parenti) di visitare il proprio profilo, nulla di quanto sopra si sarebbe verificato, poiché le frasi ingiuriose postate erano rese disponibili ad un gruppo ristretto di amici, riservate quindi ai soli soggetti autorizzati dal titolare del dato e non di pubblico dominio.
 Pertanto, se il datore di lavoro non fosse stato inserito nella cerchia di amici della lavoratrice non avrebbe visualizzato il commento ingiurioso, non avrebbe comminato il licenziamento per giusta causa e non avrebbe potuto comminarlo anche nel caso in cui, allertato da terzi che potevano visionare il commento, avesse creato un profilo fake per farsi inserire nella cerchia di amici e utilizzare il post offensivo come prova per il licenziamento.
Pertanto, se il datore di lavoro non fosse stato inserito nella cerchia di amici della lavoratrice non avrebbe visualizzato il commento ingiurioso, non avrebbe comminato il licenziamento per giusta causa e non avrebbe potuto comminarlo anche nel caso in cui, allertato da terzi che potevano visionare il commento, avesse creato un profilo fake per farsi inserire nella cerchia di amici e utilizzare il post offensivo come prova per il licenziamento.
Anche il profilo fake è punibile
La creazione di un profilo fake per intrufolarsi negli affari dei dipendenti, infatti, costituisce un’indebita intrusione del datore di lavoro nella sfera privata del lavoratore violando anche i principi di buona fede e correttezza, posto che il lavoratore abbia consapevolmente deciso di utilizzare un filtro privacy elevato. Esistono altri casi esaminati dalla Cassazione che portano sempre in evidenza questo conflitto. Occorre quindi trovare un equilibrio tra le parti, volto a rendere il più trasparente possibile l’utilizzo dei social in azienda.Come si può intervenire per riportare armonia?
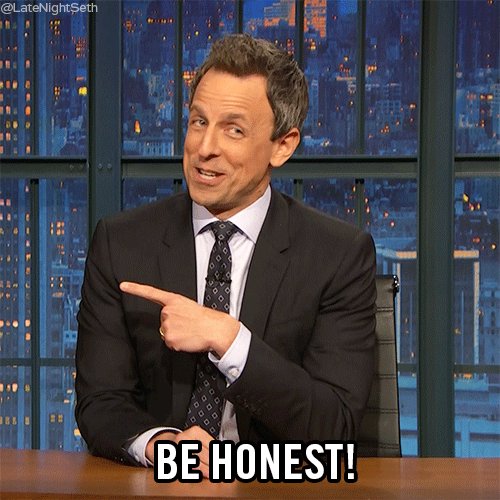 Lato aziendale sarebbe opportuno adottare adeguate e dettagliate policy che regolamentino l’utilizzo dei social in azienda e il comportamento che il dipendente deve mantenere sui social quando “parla” dell’azienda.
Una buona policy deve:
Lato aziendale sarebbe opportuno adottare adeguate e dettagliate policy che regolamentino l’utilizzo dei social in azienda e il comportamento che il dipendente deve mantenere sui social quando “parla” dell’azienda.
Una buona policy deve:
- essere esposta nelle bacheche aziendali, essere reperibile sul sito web aziendale se presente, direttamente sulla piattaforma social, nella intranet aziendale o in ogni caso consegnata anche a mano al lavoratore;
- portare a conoscenza del lavoratore che quando utilizzerà il suo profilo social, per fini lavorativi, potrà per esempio essere sorvegliato a distanza dal datore di lavoro. Il lavoratore dovrà sapere preventivamente cosa potrà fare con quel profilo e cosa non potrà fare, quali immagini condividere, quali amici aggiungere ecc.
- enfatizzare, in modo chiaro e trasparente, gli aspetti di rilevanza disciplinare collegati all’utilizzo del brand aziendale sui social;
- fornire indicazioni chiare, precise non fraintendibili volte ad adottare i giusti comportamenti da seguire sui social quando si parla del brand dell’azienda;
- fornire indicazioni relativamente all’utilizzo dei social per fini personali durante l’orario di lavoro;
- disciplinare il corretto utilizzo degli strumenti tecnologici utilizzati per lavoro;
- contenere la gestione del rischio reputazionale;
- contenere un codice di autodisciplina e un codice etico;
- essere scritta in modo collaborativo acquisendo il parere di diverse funzioni aziendali: legale, marketing, HR, customer care, direzione commerciale ecc
- essere sindacalmente compatibile: scritta al fine di non ledere interessi dei lavoratori







